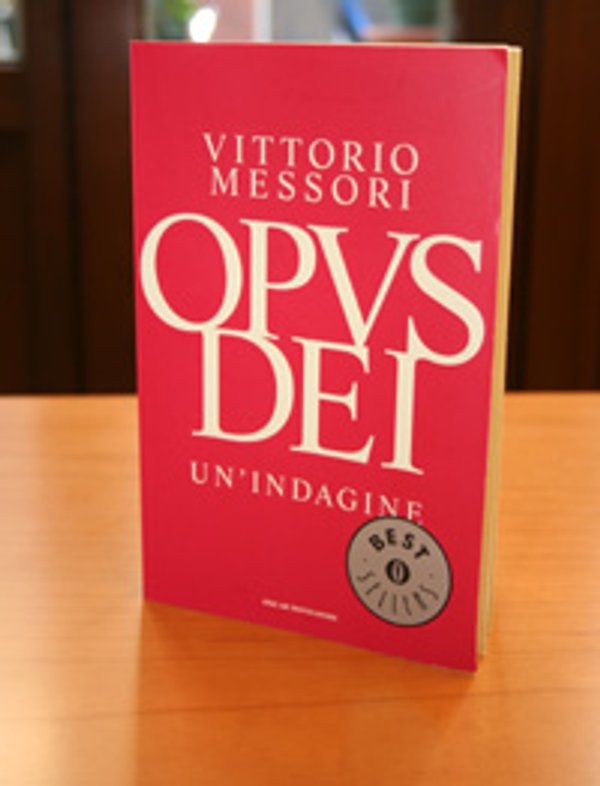Comunque, eccovi qui il dossier. Non sono un novellino, metto in giro carta stampata da parecchio tempo. Ne ho viste, ne ho sentite e ne ho dette tante. Dunque, prevedo con chiarezza certe reazioni. Le più vivaci non verranno, probabilmente, dai “cattivi mangiapreti”. Verranno, magari, da certi “buoni cattolici” (e uso l’aggettivo senza ironia: a nessuno ho mai negato a priori almeno la buona fede. Ed era lo stesso don Escrivá a confidare, sospirando, che la persecución peggiore gli venne – per tutta la vita, ma continuò, come vedremo bene, anche dopo la morte – da los buenos all’interno della Chiesa stessa).
Tra coloro che troveranno questo rapporto troppo benevolo, i più generosi mi sospetteranno di ingenuità, per non avere capito il trucco occulto che sta sotto certe apparenze edificanti dell’Opus Dei. Un naïf che è stato circuito; oppure, un superficiale che non è stato in grado di scorgere cosa ci sia davvero “sotto” o “dietro”.

Altri, meno gentili, diranno che questa non è “un’indagine”, come annuncia il titolo, ma una “apologia”, per giunta malamente travestita; magari, pure prezzolata. E se non proprio il denaro, ciò che mi ha mosso le dita sulla tastiera deve essere stato il pregiudizio positivo, forse la faziosità settaria.
Non ho altra replica se non la sola possibile al cronista: riferisco dei fatti, non delle impressioni. Mi baso sempre e solo su ciò che ho visto e su ciò che sta nelle fonti scritte, ufficiali o no che siano. Ed è su questi fatti e su quelle fonti che attendo, semmai, smentita. Se qualcuno è in grado di fare meglio, lo leggerò con gratitudine. Ciò che a me è riuscito di raccogliere (e di capire, dopo averci rimuginato sopra a lungo) sta qui.

Ho cercato soprattutto di comprendere – io per primo – che cosa sia, come “funzioni” quest’Opera, quali siano i “meccanismi”, sia mentali che istituzionali, che la muovono. Un lavoro di informazione, dunque: e che deve fare di diverso un giornalista? È un lavoro che può avere ovunque – e non qui soltanto – conseguenze positive per la convivenza fra gli uomini.
Non è casuale l’esergo che ho posto in apertura, e che è tratto dall’opera di un cristiano antico, dunque di qualcuno cui la charitas stava particolarmente a cuore: “si smette di odiare allorché si smette di ignorare”. Ammoniva qualcun altro – nella stessa linea - che, se si vuol continuare a diffidare di qualcosa o di qualcuno, bisogno evitare con cura di conoscerli (…).
Quanto alla mia prospettiva di credente (ricordata con chiarezza fin dalle prime righe), penso che possa essere di aiuto, piuttosto che di ostacolo, per capire cosa sia l’Opus Dei. Così come sarebbe di aiuto nel comprendere ogni altra istituzione cristiana, a cominciare dalla Chiesa stessa. Le ragioni cerco di spiegarle in un capitolo apposito, il settimo. Per anticipare la sostanza, e pur rinviando per ulteriori considerazioni non solo a quelle pagine, ma anche a tante altre di questo dossier (…): ogni esperienza religiosa può essere legittimamente valutata solo con strumenti adeguati. E, dunque, con categorie anch’esse religiose.
Nella convinzione profondo dei suoi ottantamila membri di tutte le nazionalità del mondo, l’ingresso e la militanza nell’Opus Dei sono, innanzitutto, un’esigenza spirituale e un’esperienza di fede. Senza mettere questo in conto, si rischia di non capire. O, peggio (come si dirà), di capire cose sbagliate.