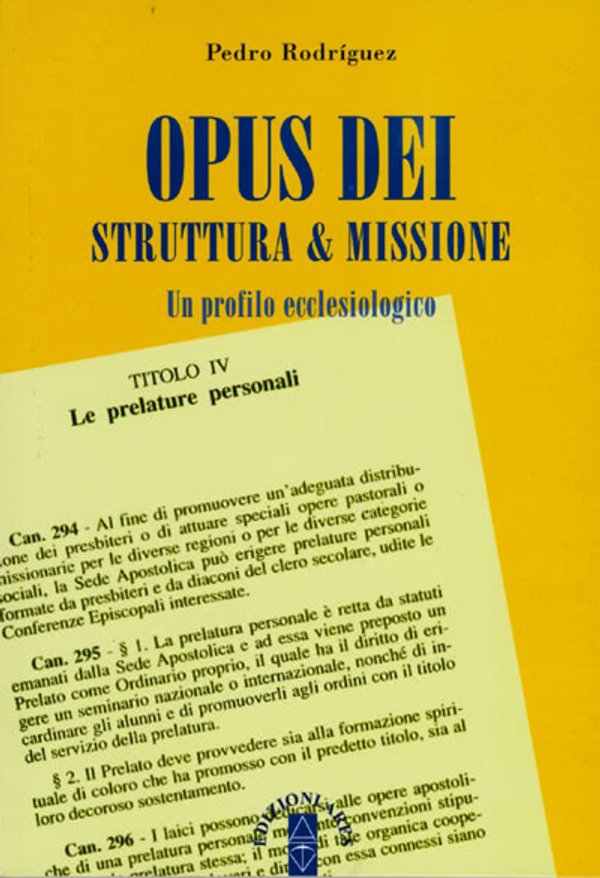La Cost. Apost. Anglicanorum coetibus, con la quale Benedetto XVI ha previsto la possibilità di erigere Ordinariati personali per i gruppi di anglicani che desiderano la piena incorporazione nella Chiesa Cattolica, ha per le relazioni con la Comunità Anglicana, e per l’ecumenismo in genere, un’eccezionale importanza [1]. È sorto già il primo Ordinariato: l’Ordinariato personale di Nostra Signora di Walsingham [2].
Inoltre, nell’ambito della canonistica l’evento ha conferito nuova attualità al dibattito sulle forme gerarchiche di natura «personale»: Ordinariati militari, Prelature personali, ecc.[3]. Questa materia sembra essere un settore peculiare del diritto canonico, e indubbiamente lo è; però, dopo il Concilio Vaticano II, dev’essere affrontata in radice dalla teologia e attraverso la teologia: in concreto, dall’Ecclesiologia quale parte della Teologia dogmatica. È noto che la teologia dogmatica de Ecclesia, per la sua scarsa tradizione – gli ecclesiologi si sono formati quasi sempre nell’ambito classico della Teologia fondamentale [4] –, ha riflettuto poco sulle «istituzioni» e sulla «struttura» del sacramentum Ecclesiae. Ed è per questo che l’Ecclesiologia dogmatica, a partire soprattutto dal patrimonio dottrinale del Concilio Vaticano II, deve impegnarsi nella materia e contribuire a una riflessione che possa arricchire la scienza teologica e, nello stesso tempo, essere un servizio all’inquadramento canonico delle istituzioni.
Non si dimentichi che la intentio dei lavori che confluirono nel Codice di Diritto Canonico (1983) consisteva, secondo Giovanni Paolo II, nel «rispecchiare la ecclesiologia proposta soprattutto dal magistero del Concilio Vaticano II visto nel suo insieme e, in modo particolare, dalla sua dottrina ecclesiologica» (cfr Rodríguez, 1983).
Per questo, il dibattito giuridico, teologico ed ecumenico in occasione della Anglicanorum coetibus mi ha spinto a indagare di nuovo e a cercare di esporre in maniera unitaria la realtà ecclesiologica dell’Opus Dei [5].
Questo richiede, prima di tutto e con una certa ampiezza, di esaminare la struttura originaria della Chiesa sacramentum salutis e la sua relazione col sacerdozio di Cristo (cap. I). Poi, di studiare gli sviluppi storici di questa struttura originaria e le forme in cui si manifestano (cap. II). Dopo di che, possiamo passare, fondatamente, a collocare il fenomeno ecclesiologico della prima e finora unica Prelatura personale della Chiesa Cattolica, l’Opus Dei: come iniziativa dello Spirito (cap. III), nella sua forma istituzionale (cap. IV) e in alcuni caratteri strutturali di particolare rilievo (cap. V). Lascio per il capitolo finale una considerazione su come l’Opus Dei realizza ciò che è la ragion d’essere delle Prelature personali: il servizio alle Chiese particolari e alla loro comunione nella Chiesa universale.
Questo libro vorrebbe dare un contributo allo sforzo di teologi e canonisti nel presentare, in un contesto ecumenico, la struttura fondamentale della Chiesa.
Pedro Rodríguez
[1] Porta la data 4 novembre 2009; testo italiano in Insegnamenti di Benedetto XVI, V, 2 2009, 490-494.
[2] Eretto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede in data 15 gennaio 2011. È il primo Ordinariato personale nel territorio di Inghilterra e Galles e ha come patrono il beato John Henry Newman. Lo stesso giorno papa Benedetto XVI ha nominato Ordinario il reverendo Keith Newton.
[3] Alla luce dell’ecclesiologia che esporremo nei capitoli I e II (cfr soprattutto, cap. I, 2, b e cap. II, 2-3), sembra che gli Ordinariati della Anglicanorum coetibs, a differenza delle Prelature personali, tendano teologicamente a future nuove forme (personali) di Chiesa particolare.
[4] Un nuovo quadro ecclesiologico della Teologia fondamentale, nella prospettiva del Concilio Vaticano II, è, per esempio, offerto da González Montes (2010) e Izquierdo (2002).
[5] Le presenti riflessioni hanno il loro background nel mio contributo a Rodríguez/Ocáriz/Illanes, 1993, 21-133.